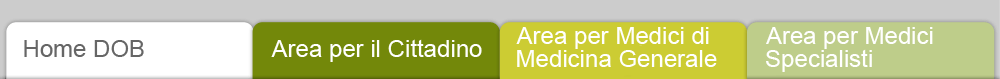
area medici di medicina generale
Linfocitosi
Un incremento del numero assoluto dei linfociti del sangue periferico al di sopra dei valori di normalità può osservarsi in numerose patologie infettive e soprattutto di natura virale.
Per linfocitosi assoluta si intende un numero di linfociti superiore a 4000 per mm3.
Per linfocitosi relativa si intende invece una percentuale di linfociti > 50% dei leucociti totali, ma con numero assoluto di linfociti normale. Questo si verifica, di solito, quando il numero dei neutrofili è ridotto, per cui sarebbe più appropriato parlare di neutropenia, o quando siamo in presenza di un’inversione della formula leucocitaria, in assenza sia di linfocitosi che di neutropenia (condizione molto frequente, ad esempio in corso di infezioni virali anche banali, o come condizione priva di significato clinico)
Prima di procedere oltre nell'iter diagnostico è opportuno ripetere l'esame emocromocitometrico a 15-30 giorni di distanza, a meno che il numero dei linfociti non sia particolarmente elevato o il paziente non sia sintomatico.
Le cause di linfocitosi benigne possono essere:
| A morfologia reattiva | A morfologia non reattiva |
| Mononucleosi (EBV) | Pertosse |
Infezioni mononucleosi like-syndromes:
|
|
Altre infezioni virali:
|
Stress linfocitario transitorio |
| Reazione farmacologica | Persistenza linfociti B policlonali |
La diagnosi di linfocitosi secondaria alle infezioni virali è di solito esemplificata dalla presenza di elevati titoli anticorpali IgM specifici del virus coinvolto (es. IgM anti-EBV, IgM anti-CMV ecc.). L’esame emocromocitometrico evidenzia una linfocitosi assoluta e relativa (5.000-40.000/mL) che a volte può essere accompagnata da una anemia e/o piastrinopenia autoimmune. L’esame morfologico dello striscio periferico spesso evidenzia dei linfociti che presentano caratteri di attivazione fino allo stadio immunoblastico (frequente nella mononucleosi). L’esame immunofenotipico delle sottopopolazioni linfocitarie ematiche evidenzia un’inversione del rapporto tra i linfociti CD4 e CD8, alterazione che tende a regredire dopo qualche settimana. Generalmente i linfociti CD8+ cosidetti “attivati” coesprimono l’antigene “DR”.
Una linfocitosi reattiva si può osservare anche dopo l’assunzione di alcuni farmaci come la fentoina; in questi soggetti la conta leucocitaria è variabile e spesso la linfocitosi si accompagna ad eosinofilia e neutrofilia.
Difficilmente si può trovare un quadro di linfocitosi reattiva dopo una infezione batterica, ad eccezione, forse, della infezione da Bordetella pertussis (pertosse) che spesso si manifesta nei bambini scatenando una importante faringite e linfoadenomegalia laterocervicale, con una conta linfocitaria che raggiunge i 10.000 – 30.000/μL, assosciata anche a neutrofilia.
La linfocitosi da "stress transitoria" di solito moderata (6.000 e 8.000/μL) si osserva, occasionalmente, in pazienti con infarto del miocardio, traumi, stato epilettico e altre condizioni patogene acute.
La "persistenza di linfocitosi policlonale tipo B", è una linfocitosi benigna di più frequente riscontro nelle donne. La causa è sconosciuta, ma c’è una stretta correlazione col fumo di sigarette. I pazienti sono spesso asintomatici; l’unico segno è dato da una conta linfocitaria assoluta mediamente elevata solitamente non superiore ai 10.000/μL su circa 15.000/μL leucociti totali.
Linfocitosi nei disordini linfoproliferativi maligni
La leucemia linfoblastica acuta (LLA) è un’emopatia maligna caratterizzata dalla proliferazione clonale e dall’accumulo di cellule linfoidi immature. La LLA si riscontra più frequentemente nel bambino, nel quale rappresenta la più comune forma di leucemia, ma si riscontra anche negli adulti e anziani. Nell’adulto l’incidenza è di circa 1/100.000/anno, è molto più rara delle leucemie acute mieloidi e costituisce il 20% del totale delle leucemie acute.
La diagnosi differenziale con la leucemia linfatica cronica (LLC) è generalmente facile e alla portata del medico non specialista. L’età adulta-senile del paziente, la scarsità di sintomi, i reperti dell’esame emocromocitometrico e dello striscio di sangue periferico consentono per lo più l’esclusione di altre condizioni. La LLC è un’emopatia maligna caratterizzata dalla progressiva espansione di piccoli linfociti maturi.

